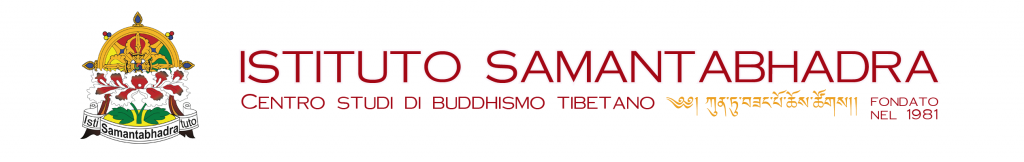Guerra Russia-Ucraina, Amelia e il canto infinito
martedì, Marzo 22nd, 2022Annalisa Cuzzocrea

Amelia Anisovych ha sette anni e incredibilmente nessuna paura. Avanza a piccoli passi, nelle sue scarpe d’argento, su un palco buio ed enorme. Vede il segno bianco disegnato per terra, lì dove le hanno detto di stare. Fa un salto per andarci sopra. Davanti a lei un mare di luci, tenute su dalle decine di migliaia di persone che riempiono l’Atlas Arena di Łódź, in Polonia. Dietro di lei, un’orchestra muta. In ascolto.
Amelia prende fiato come due settimane fa, quando era in un rifugio antiaereo di Kiev. Prende fiato, e canta. Stavolta non è la canzone di Frozen, quella che ricordava tutta a memoria e che per questo le dava sicurezza. «Perché una volta all’asilo volevo cantare e non ricordavo le parole, mi sono fermata e ho detto mai più, non succederà mai più».
Stavolta Amelia Anisovych canta l’inno nazionale del suo Paese e in uno stadio strapieno non si sente un respiro che non sia il suo. Così come in quel bunker, pieno di terrore e disperazione, tutto si era fermato per ascoltare la sua voce di cristallo ripetere un motivo che conoscono i bambini e i genitori di tutto il mondo. Per poi esplodere in un «bravo!», mentre lei portava le mani alla bocca per l’emozione e la gioia di essere arrivata, stavolta, fino in fondo.
Se fosse una favola, se in questo tempo impazzito esistesse ancora qualcosa di giusto, quella voce fermerebbe la guerra, le bombe, i missili supersonici, la distruzione, le fosse comuni nelle trincee, le irruzioni casa per casa, la ricerca dei tatuaggi sui corpi, delle foto di soldati sui telefonini. Fermerebbe i carri armati e i colpi di mortaio e le schegge che hanno colpito bambini come Amelia. Uccidendoli, ferendoli, menomandoli.
Ci sono troppi bambini in questa guerra. Vediamo troppi bambini con i loro peluche e gli animali domestici e gli unicorni colorati. Ci sono troppi bambini e troppa innocenza tradita in ogni guerra. Quando abbiamo visto Aylan Kurdi riconsegnato dal mare sulle rive di Bodrum, abbiamo pensato: «Mai più». Perché con la sua maglietta rossa e le sue scarpe allacciate assomigliava ai figli che vediamo dormire nelle nostre case. E il pensiero che ci siano figli come i nostri in Siria, che soffrono, scappano, muoiono in un naufragio, gelano nel bosco che li separa da un posto che chiamiamo Europa, ci era d’un tratto diventato insopportabile.
Ma la foto di Aylan è sbiadita e con lei le nostre buone intenzioni. I video di Amelia che canta nel rifugio e poi su un palco, proprio come aveva detto di sognare, sono l’incantesimo che mostra al mondo cos’è giusto e cos’è sbagliato. Cosa ha senso e cosa non ne ha. Per dirla con un linguaggio forse lontano dalle ragioni dalla geopolitica, ma vicino al pensiero dei bambini – e dei filosofi – mostrano dov’è il bene e dov’è il male. E sì, se fosse una favola fermerebbero tutto.