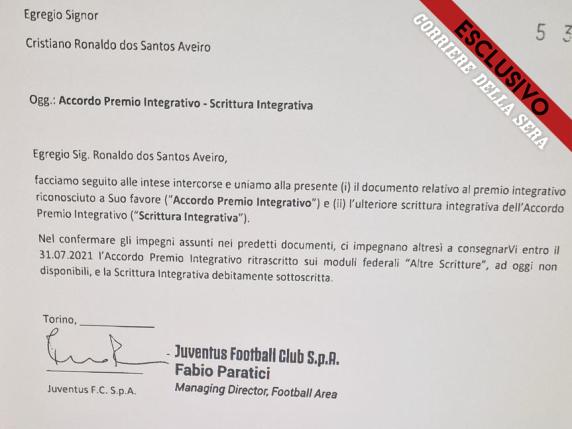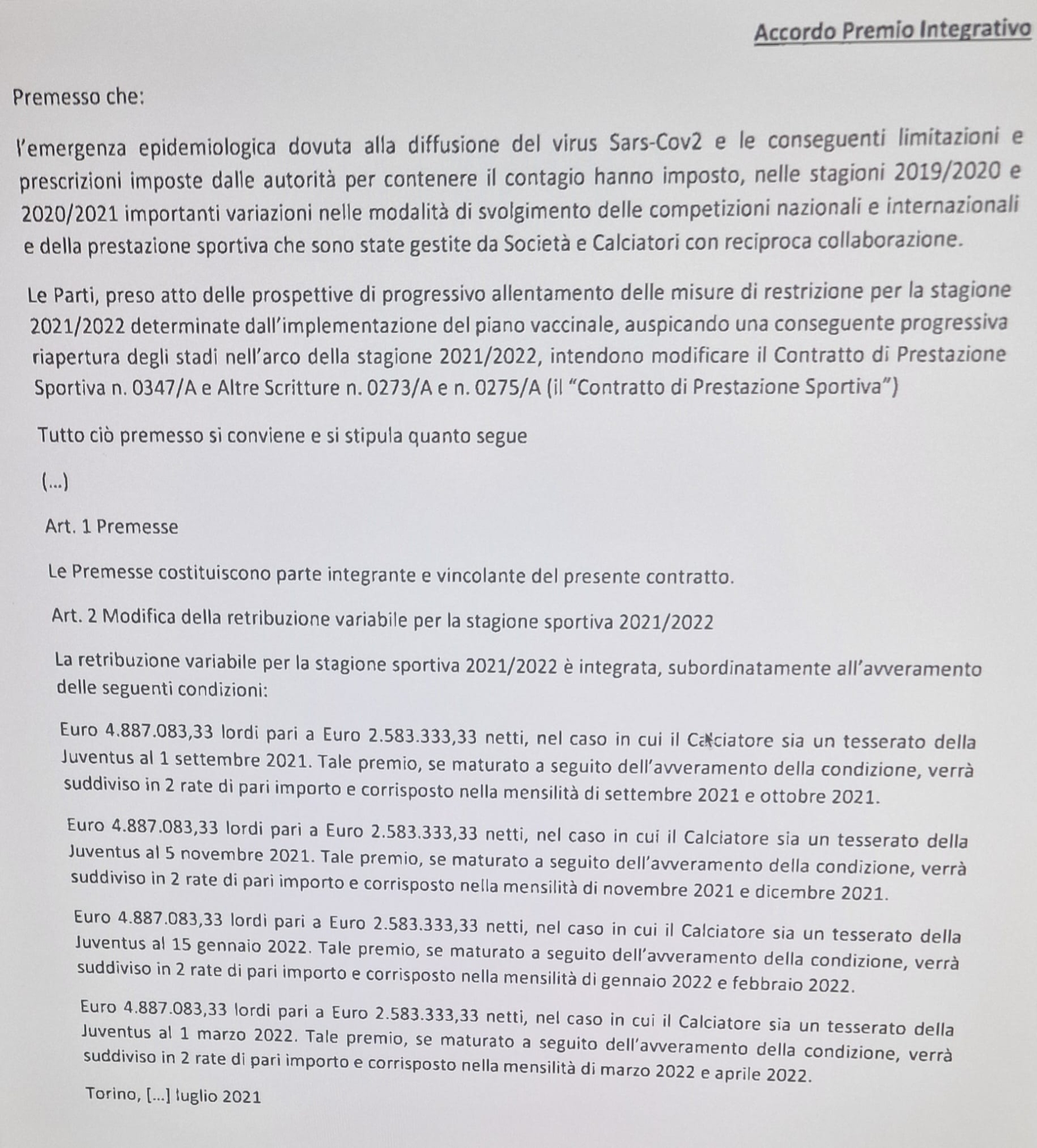Concita De Gregorio
Non mi preoccuperò, nello scrivere queste righe, delle
reazioni che scatenerà sui social domattina. Ce la posso fare, devo solo
pensare alla vita di prima. Me lo ricordo, quando la libertà di dire
non era mai in nessun momento attraversata dal pensiero: pensa che
giornata mi aspetta domani. Era meglio, senza un filo di dubbio. Era
sano lavorare senza la preoccupazione preventiva del sabba infernale che
comunque, anche se ti sforzi di ignorarlo, non ignora te: entra dagli
interstizi, si fa spiffero e poi tempesta, c’è sempre un amico che ti
avvisa: sei in tendenza, hai visto? Tendenza. Che parola assurda, senza
l’indicazione di un approdo. Verso cosa tende, esattamente, questa
tendenza? Che trappola. La reputazione, la popolarità. E invece, pensa:
prima contavano l’identità, l’autorevolezza.
La costruzione di una reputazione a uso del popolo del web là fuori
(in verità là dentro: stanno tutti a casa loro) ha fagocitato
l’identità. La popolarità e il consenso hanno preso il posto della
competenza, della fatica che serve. Non importa chi sei, importa quello
che fai credere di essere. Funziona così. Non penserai mica di
sottrarti? Se esci sei fuori, fuori piove. Fa freddo. Nessuno ti vede,
smetti di esistere. Esci dal mercato, non te lo ha spiegato il tuo
agente? Ho vissuto cinquant’anni senza un’agente, rispondevo prima. Ma
allora sei scema. E un assistente, un social media manager, un
consulente per l’immagine? No, niente, ma siccome è una conversazione da
binario morto non lo dico più.
Ora però. Mi pare di intravedere qualche piccolo, timido indizio di
saturazione perciò ripeto qui la proposta che feci anni fa all’uomo più
illuminato che abbia mai conosciuto il quale mi rispose, saggio: è
presto. Forse tra poco sarà tardi, però. Allora, amici: usciamo dai
social. Non esistono senza di noi. Si sono impadroniti delle nostre vite
per il semplice motivo che gliele abbiamo consegnate. Vivono del nostro
sangue che gli forniamo ogni giorno: una bella edificante foto su
Instagram, un post che ci renda interessanti e certo migliori di quello
che siamo, che nasconda per carità le nostre fragilità, le vite occulte,
le nostre vere pulsioni e passioni. E invece: un pensierino, una
provocazione, un ricordo accorato, una foto col morto del giorno che
certifichi io c’ero, lo conoscevo. Guardate come sono giusto, opportuno,
apprezzabile. Ma se non gli dessimo materia, ai mangiamorte, ci
pensate? Non esisterebbero.
Lo so, ci sono milioni di persone che ci lavorano: per mancanza di
alternativa, sovente. I social media manager, i costruttori di immagine
del politico, della celebrità. Ma siamo sicuri che facciano un lavoro
utile a loro e a noi, camuffando continuamente la vera natura delle
persone? La disillusione, il sospetto, il complottismo che dilaga, il
non ce la contate giusta non nascono anche dalla costante dissimulazione
della verità come imperativo? La verità, insomma: sparita dietro la
rappresentazione. Parli con il mio addetto stampa, con il mio manager,
non è una bella risposta da sentirsi dare e neanche una bella frase da
dire.
Le persone migliori che conosco non sono sui social. Senza offesa per
chi ci campa e lo capisco: i mestieri di una volta non ci sono più,
questo è il mondo come va, bisogna arrangiarsi e starci. Però ripeto:
statisti, inventori, poeti, navigatori, gente che pensa e scrive e
lavora a costruire mondi. Gente che accudisce persone. Gente che lavora
tutto il giorno e che poi si dedica a chi ha intorno, fisicamente: che
parla e guarda in faccia chi c’è. Non sono sui social. Non hanno il
tempo per farlo, né l’interesse. Hanno da fare.
Che poi. Pensavo leggendo le cronache sul Grande Latitante. Hai
vissuto trent’anni alla luce del sole, a casa tua. A parte le complicità
che certo ci sono e ci sono sempre state, le massonerie, i piccoli
politici locali che hai fatto votare e ti hanno protetto, le borghesie
contigue con la mafia, le connivenze, va bene. Ma per non essere notati
la cosa più semplice è sempre la stessa: non esibirsi, stare nei propri
panni. È quando vuoi essere notato che hai bisogno di avere tribuna: un
megafono social
serve a questo. Quindi prendiamo nota: senza un profilo Facebook o
quello che sia, TikTok la dannazione, puoi persino latitare per decenni.
Potremmo noi, che non siamo Messina Denaro, vivere sereni la nostra
vita di prima: fare cose che ci va di fare e di dire, o non farle, e
tornare a essere chi siamo. Restare chi eravamo.
Il grande problema è il terrore di non essere all’altezza delle
aspettative altrui. Familiari, professionali, sociali: se scoprono chi
sono davvero son rovinato. Dissimulare, costruire vite da recitare,
recitarle (i professionisti dello spettacolo sono, in questo, in
effetti, avvantaggiati: possono mettere in scena vite domestiche come
fossero un film d’autore). Ne parla Niccolò Ammanniti nel suo ultimo
libro, La vita intima (Einaudi): nell’intervista che Annalisa Cuzzocrea
gli ha fatto su La Stampa, dice cose semplici e mirabili. Intanto,
appunto, niente social. Non c’è tempo, la vita è una ed è breve.
Ma poi: quanta energia, quanto tempo e lavoro quanta ansia ci costa
sembrare diversi da quello che siamo. E perché. Per chi? Pensate ai
ragazzi: alle loro vite tutte quante virtuali, ormai, al sesso imparato
sui siti porno alle relazioni mediate dal giudizio del mondo intero, un
mondo sconosciuto. Se parlo con qualcuno che ho di fronte so a chi
parlo, se parlo con il web non so chi mi ascolta: e come faccio, se ho
12 anni, a piacere a chi mi ascolta senza sapere chi è? Posso solo fare
come mi dicono di fare, imitare quelli già popolari. Essere uguale a
qualcuno, rinunciare a essere chi sono. È una tragedia, per i ragazzi.
Molto più che per noi. Ma è reversibile? Si può uscire dai social?
Possono, gli adolescenti, tornare a parlarsi? Dipende anche da noi.
Loro arrivano nel mondo che gli abbiamo apparecchiato. Possiamo
sparecchiare.
C’è qualche timido segnale, dicevo. «Prospettive economiche più deboli per i colossi di Silicon Valley», leggo. Dopo Amazon, Facebook,
Tesla (Twitter) ora tocca a Microsoft licenziare: diecimila dipendenti
di troppo. Qualcosa si è rotto. Non sembrano averlo compreso i grandi
gruppi editoriali che abbandonano la carta (e la qualità, e le
competenze, e la storia delle persone e delle cose) per inseguire i
clic, la pubblicità, un mercato vicino al punto di collasso. È una gara a
perdere, alla lunga: economicamente, culturalmente. Piantare semi, si
dovrebbe. Non raccogliere frutti di alberi esausti. «La verità è nelle
mani, negli occhi e nel silenzio», scrive Christian Bobin, poeta. La
paura di non piacere, l’ansia di nascondere le nostre debolezze ci ha
portati al più fasullo dei mondi che pretende da noi ogni momento
qualcosa di più: che ci consegniamo, come comparse.