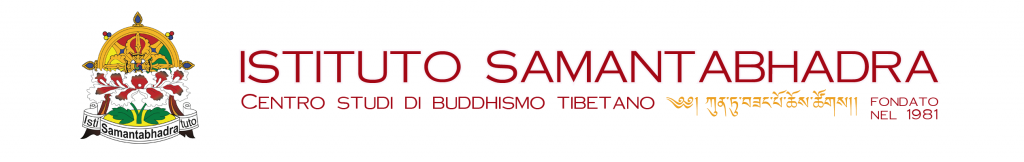Anni di piombo e di tritolo: vent’anni tra brigate rosse e attentati neri
Un processo di modernizzazione tanto stridente e rapido ha bisogno di essere governato dalla politica: serve un processo di riforme capace di colmare i ritardi e le diseguaglianze, di superare le contraddizioni istituzionali, di avviare la nazione su una strada di profonda trasformazione culturale. Gli spazi di mobilità sociale aperti dalla crescita economica, l’affrancamento di soggettività sino ad allora represse, l’inizio della scolarità di massa, la massiccia deruralizzazione e la conseguente concentrazione urbana, la diffusione della cultura del consumo e della comunicazione mettono in crisi la rappresentatività del sistema politico tradizionale: occorre una nuova sintesi, che sappia gestire il cambiamento coniugando insieme libertà ed equità sociale. Ed è esattamente questo che in Italia non c’è stato, con la conseguenza di trasformare la penisola in un “paese mancato”. L’esperimento del centro-sinistra di Moro, Nenni e Fanfani esaurisce la propria spinta propulsiva con due riforme iniziali (la nazionalizzazione dell’energia elettrica e la scuola media unica), fermandosi di fronte alle resistenze degli interessi costituiti più retrivi e ai minacciosi “tintinnar di sciabole” dei settori favorevoli ad una soluzione autoritaria “sudamericana”. La formula politica sopravvive, non l’obiettivo per la quale è nata.
Il movimento di contestazione del 1967/68 raggiunge così il nostro Paese nel momento in cui la distanza tra le due Italie ha raggiunto il punto di maggior divaricazione, esasperando i contrasti generazionali e radicalizzando le posizioni politiche; l’anno successivo le lotte per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici traggono alimento dal clima di tensione sociale in cui si sviluppano e, a loro volta, lo alimentano con il protagonismo di una nuova classe operaia, immigrata e deprofessionalizzata, insofferente delle prudenze sindacali, carica di rabbia per l’alienazione della fabbrica in cui lavora e l’emarginazione dei quartieri-ghetto in cui vive. La saldatura dei due movimenti si esprime nell’eruzione sociale dell’”autunno caldo”, con una classe dirigente impreparata e incerta, che a destra viene accusata di non saper garantire l’ordine e a sinistra di rispondere alle richieste solo con la repressione.

IL TRITOLO DI PIAZZA FONTANA
In questo clima ci sono state avvisaglie di violenza politica, come gli scontri di Valle Giulia a Roma, o i morti di Battipaglia ed Avola, ma il vero momento di rottura è Piazza Fontana: il 12 dicembre 1969, quando il boato di un’esplosione sconvolge la filiale della Banca dell’Agricoltura, l’Italia scopre di non essere più la stessa. A destra ci sono personaggi nutriti di un profondo anticomunismo, che si sono formati nel clima di contrapposizione della Guerra Fredda, in precario equilibrio tra legittimi programmi di difesa internazionale e pericolose tentazioni autoritarie interne: ammiratori delle soluzioni golpiste dei colonnelli greci, ex militanti del Msi ora raccolti nei gruppi dell’estremismo nero, essi paventano la continua mobilitazione di piazza operaia e studentesca, le declinazioni egualitarie dei movimenti, la contestazione dei principi gerarchici, gli attacchi alle strutture della società tradizionale (la famiglia, la scuola, la fabbrica, le istituzioni pubbliche). Sono uomini di mezza età già combattenti della Repubblica sociale e giovani turbolenti ed irrequieti che in Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale trovano una cerniera generazionale. Accanto a loro, alcuni uomini dello Stato, ufficiali e funzionari dei servizi segreti abituati a muoversi ai limiti della legalità, stretti nelle contraddizioni della doppia fedeltà, da un lato verso la Repubblica e le sue dinamiche elettorali, dall’altra verso la collocazione internazionale dell’Italia nel mondo atlantico.
A quest’area più definita dell’estremismo nero, fa riscontro un’area invisibile, sfumata nei contorni e nelle dimensioni: personaggi del mondo politico in stretto contatto con le forze conservatrici fìloatlantiche, imprenditori e manager della finanza, ufficiali delle Forze Armate, intellettuali, giornalisti, accomunati da convinzioni tradizionaliste, timorosi di possibili derive di piazza, favorevoli ad un giro di vite nella gestione dell’ordine pubblico, attratti dall’idea di una trasformazione costituzionale in senso presidenzialista. Difficile immaginare che da quest’area si sviluppi un’iniziativa golpista, ma certamente essa costituisce il riferimento cui guardano i più spregiudicati per sentirsi garantiti e incoraggiati.
Piazza Fontana nasce dall’incrocio di queste dinamiche: da una parte gli elementi radicalizzati che vogliono agire, dall’altra il retroterra che fa da garanzia, connivente o meno. La miscela trasforma una potenzialità operativa (esistente in Italia sin dal dopoguerra) in potenzialità in atto e produce una strage voluta, che solo per circostanze fortuite non si replica negli altri scenari di Roma e Milano in cui sono stati posti esplosivi in quello stesso giorno. Strage politica, dunque, perché è indubbio che chi mette le bombe agisce nel duplice intento di fermare le lotte sociali che agitano il Paese e di condizionare gli equilibri politici in ridefinizione. Altra cosa, però, è parlare di “strategia della tensione” e di “strage di Stato”: efficaci sul piano della comunicazione, queste formule finiscono con l’essere fuorvianti e produrre una rappresentazione sovradimensionata rispetto alla realtà. “Strategia” implica un progetto, un coinvolgimento di più soggetti, una sequenza di azioni in cui apparati dello Stato e settori della politica perseguono un obiettivo dichiarato, una regia e un regista designato. Nei giorni successivi a piazza Fontana non ci sono né mobilitazioni nelle caserme, né appelli lanciati via etere, né proclamazioni dello stato di emergenza, né (a quanto risulta) pressioni internazionali per insediare un governo di militari ultra-atlantico e anticomunista. Devastante negli effetti umani e materiali, l’esplosione si rivela un atto eversivo senza sbocco operativo. Come tale, essa è un elemento di forte destabilizzazione, ma non provoca, per reazione, un’involuzione politica in senso autoritario: il governo di centrosinistra di Mariano Rumor resta in carica, le Camere non vengono sciolte, le piazze continuano ad essere agibili per i movimenti.

Piazza Fontana costituisce tuttavia un momento di rottura nella storia nazionale non tanto per i suoi tragici effetti immediati, quanto per il modo con cui lo Stato ne affronta la gestione. Una pista anarchica perseguita pregiudizialmente e rivelatasi infondata; un imputato caduto dal quarto piano della Questura di Milano durante gli interrogatori; un “mostro” offerto all’opinione pubblica come colpevole e scoperto innocente; un processo trasferito “inspiegabilmente” da Milano a Catanzaro e a Bari; interventi di depistaggio da parte di uomini delle istituzioni per ostacolare il lavoro della magistratura; collaboratori dei servizi segreti fatti fuggire all’estero per evitarne la cattura; un iter giudiziario durato decenni, tra condanne all’ergastolo trasformate in assoluzioni, sentenze generose passate in giudicato, latitanze in Paesi compiacenti, fughe sospette. Nell’area dell’estremismo di destra, la gestione di Piazza Fontana rafforza la convinzione che il progetto autoritario goda di un sostanziale consenso tra i gruppi di potere e che negli apparati dello Stato si trovino spazi significativi di complicità e di tolleranza: il che si trasforma in un incentivo all’azione, con le bombe degli anni successivi sino alle esplosioni del 1974 a Brescia e sul treno Italicus, la moltiplicazione delle cellule eversive, i progetti golpisti del principe Borghese e della Rosa dei Venti, le contiguità con aree che guardano a modelli presidenzialisti imposti con la forza (come la Loggia massonica P2 di Licio Gelli).
IL PIOMBO DELLE BRIGATE ROSSE
Nella sinistra, all’opposto, le ambiguità alimentano lo schematismo interpretativo, con la convinzione che la Cia, la Nato, i servizi segreti, le forze di destra, i neofascisti costituiscano un unico blocco pronto a impedire con la forza ogni evoluzione, che per via elettorale non si possa realizzare nessuna reale trasformazione, che il Partito comunista sia ormai integrato nel sistema borghese capitalistico, che la rivoluzione armata sia la prospettiva da perseguire: il commissario Calabresi diventa il simbolo della violenza del potere, Pinelli e Valpreda le vittime sacrificali di una montatura contro le piazze operaie e studentesche, gli interventi delle forze dell’ordine una minaccia continua ai movimenti popolari. La galassia della sinistra extraparlamentare, nata negli anni della contestazione, si sviluppa nella sovrarappresentazione delle trame golpiste, di cui la “strage di Stato” del 12 dicembre sarebbe palese manifestazione: la sfiducia nelle istituzioni democratiche, la delegittimazione della classe dirigente, l’accettazione della violenza come strumento ordinario e necessario di lotta politica inaugurano una stagione di fuoco, dove la convinzione che sia possibile un cambiamento radicale e repentino dell’ordine politico, sociale e culturale dominante si salda alla denuncia della reazione di uno Stato borghese, che si oppone alla prospettiva rivoluzionaria con la forza oscura del neofascismo e dell’eversione nera.

Su questo retroterra si sviluppa il terrorismo rosso, di cui le Brigate Rosse rappresentano il gruppo militarmente più organizzato, ma che conta altre sigle più o meno concorrenziali, dal gruppo XXII Ottobre, ai Gap di Gian Giacomo Feltrinelli, a Prima Linea, ai Nuclei Armati Proletari, al Partito della guerriglia. La teorizzazione più nota è quella brigatista, che definisce il mondo capitalistico “Stato imperialista delle multinazionali”, una realtà sovranazionale che ha al vertice il governo degli Stati Uniti e che usa come braccio armato la Cia, mentre le sue articolazioni in Italia sono rappresentate dalla Democrazia cristiana e dai servizi segreti deviati. Dietro l’apparente facciata democratica, lo Stato imperialista delle multinazionali è una struttura repressiva, che si oppone con la forza ad ogni rivendicazione di giustizia sociale e di progresso, favorendo colpi di stato, legislazioni d’emergenza, interventi autoritari. Compito delle avanguardie rivoluzionarie è costringere lo Stato a “gettare” la propria maschera, colpirlo nei suoi uomini e nelle sue strutture, “disarticolarlo” perché reagisca rivelando la sua vera natura violenta e antidemocratica: in questo modo le masse operaie e studentesche si schiereranno dalla parte delle avanguardie, alimentando un clima insurrezionale e preparando la svolta rivoluzionaria. Il terrorismo rosso inizia con atti di intimidazione contro capireparto e capisquadra, si sviluppa con rapimenti spettacolari (dal dirigente personale Fiat Ettore Amerio al giudice Mario Sossi), approda agli omicidi di magistrati, avvocati, giornalisti, dirigenti d’azienda, forze dell’ordine (tra gli altri Francesco Coco, Fulvio Croce, Carlo Casalegno), giunge al suo apice con il rapimento di Aldo Moro, quindi inizia un declino tanto lungo quanto sanguinoso, dove in nome del proletariato vengono uccisi i proletari (a cominciare dall’operaio genovese Guido Rossa). La distanza tra le teorizzazioni del terrorismo rosso e l’evoluzione della società italiana è evidente: gli anni 1976-80, i più cruenti per il numero di azioni compiute, sono gli stessi in cui la riorganizzazione del modo di produrre cambia completamente la composizione del tessuto sociale, mentre il “riflusso” porta alla riscoperta del privato e all’esaurirsi della dimensione collettiva del ‘68-69. Fuori dalla storia, i terroristi appaiono tanto più feroci quanto più distanti dalla società reale che vogliono cambiare: nel momento in cui uccidere diventa il modo per giustificare la propria vita e la propria scelta di clandestinità, non ci sono più strategie da perseguire (per quanto perverse), ma solo crimini da commettere per non riconoscere il proprio fallimento umano e politico.
I CONTI CON LA STORIA
Proporre il terrorismo nero e rosso in termini di successione cronologica è operazione ovvia: la paura del comunismo e delle derive rivoluzionarie è oggettivamente precedente alla denuncia di attacchi alla democrazia e al timore di trame eversive. Sarebbe tuttavia riduttivo e sbagliato considerare l’uno conseguenza dell’altro, perché entrambi si collocano all’interno di un contesto generale dove domina il tema dello sviluppo non governato: l’incapacità della classe dirigente di ricomporre il conflitto modificando gli equilibri di potere e ridiscenda un nuovo contratto sociale sono la premessa della degenerazione, alimentando da un alto la sensazione di debolezza delle istituzioni di fronte al conflitto sociale, dall’altro rafforzando la prospettiva palingenetica di una rifondazione radicale degli equilibri esistenti. Due fenomeni eversivi di segno opposto, dunque, che nascono dalla stessa realtà dell’Italia come “paese mancato” e che si alimentano l’uno con l’altro, tra azioni devastanti negli effetti e ancora più devastanti nelle rappresentazioni. E’ l’Italia malata degli anni di piombo e di tritolo, che inizia nel 1969 e continua sino a tutti gli anni Ottanta.
Alla fine, ha vinto lo Stato e ha vinto la democrazia . La liquidazione del terrorismo di sinistra ha richiesto più tempo di quella dello stragismo e del golpismo, ma i “nemici della Repubblica” sono stati sconfitti. Non si sono verificati né colpi di stato, né adozioni di legislazioni speciali, né restrizioni delle libertà. I terroristi hanno potuto difendersi con tutte le garanzie previste dalla Costituzione, anche quando hanno cercato di bloccare i processi con le ricusazioni; la legge sui pentiti ha lasciato liberi tanti assassini dopo poco tempo, ma ha permesso di smantellare le organizzazioni eversive; la dialettica politica ha continuato a percorrere la strada del voto e delle istituzioni democratiche.
Sul piano storico, però, un dubbio: erano davvero necessari 358 omicidi e centinaia di invalidi prima di vincere la guerra? Sul piano giudiziario, un altro dubbio: è possibile, dopo cinquant’anni, avere ancora tante zone grigie su chi siano effettivamente stati gli esecutori e i mandanti? La forza di una democrazia sta anche nel sapere fare i conti con il proprio passato. Sugli anni di piombo e di tritolo, come su tante altre pagine buie, non sono stati fatti, come ricordano inutilmente i famigliari delle vittime ad ogni commemorazione. E come lo ripropone, con la forza di uno schiaffo, l’arresto di qualcuno che per troppi anni si è giovato all’estero di “coperture” improprie.
*Storico
LA STAMPA
Pages: 1 2